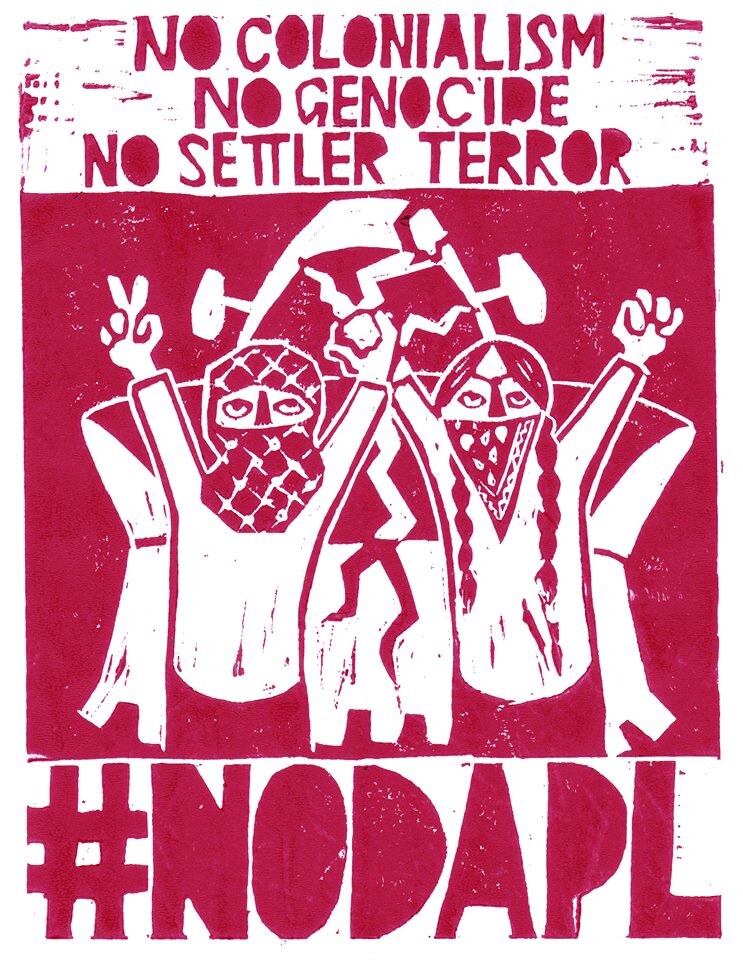Il 24 e il 25 maggio alla John Cabot University a Roma si svolgerà il workshop “The Arab Archive: Mediated Memories and Digital Flows”, un incontro di due giorni dedicato all’economia politica dell’immagine araba tra materialità, etica ed estetica della sua produzione, distribuzione e archiviazione dal 2011 in poi. Il workshop, che vedrà la partecipazione di ricercatori, attivisti, artisti e curatori dal mondo arabo e non solo, rifletterà sulla questione della rappresentazione e delle politiche della memoria nel contesto arabo, schiacciato adesso da guerre civili, violenze o processi contro-rivoluzionari. Ripensare agli archivi digitali nel mondo arabo post-2011 vuol dire interrogarsi non solo sul ruolo del passato nelle conflittualità del presente, ma soprattutto su quali sono i soggetti e i poteri coinvolti a molteplici livelli geografici, locali e internazionali, nel modellare le politiche degli archivi, particolarmente alla luce delle potenzialità della tecnologia digitali nel facilitare i processi di condivisione e archiviazione del passato. Il programma dell’evento si può trovare a questo link; qui il programma della tavola rotonda “The revolutions won’t be televised. Immagini e archivi dalle rivolte del 2011”, che si svolgerà il pomeriggio del 24 a ESC Atelier.
May amnesia never kiss us on the mouth. May it never kiss us. Così scrivevano Basel Abbas e Ruanne Abou-Rahme, artisti visuali palestinesi, in un intervento contenuto nel volume collettaneo You Are Here. Art After the Internet. Pensavano al desiderio che spinge a conservare frammenti di tempo, e a come sia possibile nel virtuale produrre e riprodurre continui archivi della contemporaneità, tramite piccole operazioni scandite dalla banale riproduzione della routine del cercare, scaricare, tagliare, incollare, copiare, documentare, caricare, postare, bloggare, twittare… Gli artisti palestinesi discutevano di quanto la dimensione e la pratica dell’archivio avesse riguadagnato centralità nei pochi anni precedenti, complice l’inversione di rotta avviata dalle nuove tecnologie che ha drasticamente infranto l’elemento statico e la processualità gerarchica dell’archivio, così come hanno testimoniato le vicende che hanno destabilizzato la regione del Nord Africa e Medio Oriente dal 2010, momento in cui siamo stati testimoni della possibilità di trasformare istantaneamente un evento in un file archiviale semplicemente riversandolo in maniera immediata nel ben più grande archivio di Internet. Ciò ha scompaginato lo scenario, presentando nuove pratiche di appropriazione, ri-archiviazione, documentazione, ri-narrazione, come prodotte in massa, ma soprattutto pubblicamente e performativamente, non solo come conseguenza e testimonianza, ma anche come componente del momento fisico di rivolta. L’idea di produrre archivi dissonanti in tempo reale, mente gli eventi si svolgono, può essere compreso, scrivevano sempre Abbas e Abou-Rahme, come un modo fondamentale per interrompere lo spettacolo del potere, e non solo condividere informazioni.
Oggi l’impulso a documentare, salvare e narrare il momento è ovunque, e la produzione collettiva e sempre crescente di archivi soggettivi, orizzontali, critici tra i paesi del mondo arabo esprime in maniera radicale il desiderio di ricominciare a interrogarsi, a partire da questo, sulle modalità di costruzione e decostruzione della storia, del passato e dell’attuale; un processo in cui per l’archivio non è solo contenimento e produzione di dati, ma soprattutto un dispositivo che può e deve mettere in discussione la sua funzione e il suo contenuto, per sovvertirlo dall’interno e renderlo vivente.

Si tratta di una discussione che da una sponda all’altra sta prepotentemente attraversando, tanto in maniera teorica quanto pratica, i paesi del Nord Africa e Medio Oriente, tagliando trasversalmente geografie e temporalità, per diventare oggetto di pratica e discussione da parte di ricercatori, studiosi, ma soprattutto attivisti e artisti.
In questi anni, lo slancio politico e il potenziale liberatorio, la vitalità creativa che si impone di salvare il desiderio dall’egemonia della cannibalizzazione archiviale così come è stata conosciuta finora, quella dello spettacolo del potere, ha dimostrato di essere espressione anche di un riguadagnato diritto alla parola, di un’assunzione di agentività. La genesi di tali dissonanti e proliferanti archivi, dalla Tunisia all’Egitto, dalla Siria alla Palestina, è allora in sé un atto di dissenso e di resistenza dalla trappola della rappresentazione, una delle tante possibili articolazioni della creazione di un nuovo radicale immaginario politico. È pur vero che un eccesso di informazioni potrebbe paradossalmente portare all’amnesia, ed è questo che potrebbe accadere dinanzi al flusso straripante e troppo accelerato di dati auto-prodotti nell’archivio digitale, tuttavia questo non deve condurre a una derubricazione dell’atto archiviale. Bisogna allora affrontare la questione allargando lo sguardo verso un nuovo immaginario.
Qui, praticare l’archivio vuol dire non solo contrastare la monopolizzazione della memoria degli archivi ufficiali, o l’obliterazione di memorie altre, sopraffatte dalla verticale gravità del potere, ma soprattutto ricostruire un nuovo senso di archiviare, che nasce soprattutto dalla ridefinizione di chi può farlo, e dalla plasticità linguistica e testuale di ciò che compone l’archivio. Un percorso che ha a che fare tanto con la memoria che con la creazione di un percorso per il futuro, poiché l’intento di questi archivi non è solo il preservare, quanto il localizzare le testimonianze come strumenti di resistenza e farle circolare; oltre alla possibilità di creare alleanze trasversali contro le privatizzazioni dell’archivio, ma soprattutto contro l’egemonia delle narrazioni della storia, della distribuzione del potere e del disciplinamento del dissenso.
Di immagini, spettacolarizzazione e cannibalizzazione, particolarmente nello scenario siriano, abbiamo discusso recentemente con Donatella Della Ratta, organizzatrice del workshop che si terrà alla John Cabot University e docente di Communications and Media Studies presso la stessa università statunitense a Roma. Donatella Della Ratta è stata ospite della TRU e del Centro Studi Postcoloniali e di Genere del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (Università L’Orientale di Napoli) lo scorso aprile per un seminario sul suo libro di prossima uscita per Pluto Press, Shooting a Revolution: Visual Media and Warfare in Syria, e per una performance svoltasi presso L’Asilo, dedicata alla Siria e all’archivio personale di immagini della rivoluzione di Bassel Khartabil aka Safadi, attivista pacifista siriano, scomparso e poi morto nelle carceri siriane, parte attiva di quella comunità di arab geeks e techno-savies, che aveva contribuito a formare una cultura digitale in Siria e nel mondo arabo e a dare un contributo attivo agli effettivi sommovimenti sociali scoppiati nella regione tra il 2010 e il 2011.

Quello di cui Bassel Khartabil era un appassionato esponente era una forma di cultura digitale che nello scorso decennio ha travalicato i confini nazionali, riconnettendo gli arabi a diverse latitudini e contesti, in una dimensione collettiva e reticolare, accomunata in maniera sinergica e solidale (e le campagne per la liberazione dei mediattivisti detenuti ne sono ancora un esempio) da una visione della tecnologia come possibilità trasformativa della società: tecnologia significava tanto il simbolo della libertà di espressione quanto lo strumento attraverso cui conquistarla. Un’idea per cui le pratiche legate alla tecnologie digitali del curare, proporre contenuti, condividerli, erano e sono indistricabilmente legate a riconnettere il mondo dell’online con tutto quello che c’è fuori, il virtuale con le molteplici pratiche dell’attivismo sociale, in un’ottica che non ha nulla a che vedere con un determinismo tecnologico, ma che guarda a come l’ecologia e la pratica della cultura digitale (nei suoi molteplici aspetti, dal coding al blogging) possa avere informato un network di relazioni e sviluppato progetti per promuovere la libertà di espressione, di condivisione di informazioni, di coscienza dell’open source, e in definitiva, un cambiamento politico e sociale.
L’esplosione degli archivi digitali sembra poter riportare indietro tutto questo, rimostrando con vigore questa cultura dell’attivismo digitale, costretta negli ultimi anni a sopravvivere in uno scenario fagocitante, in cui sono diventati bulimici la produzione e il contenuto di immagini e visioni opposti e violenti, in cui i soggetti sono definiti e determinati dall’immagine, un’immagine violata che non è più rappresentazione, né tantomeno testimonianza, piuttosto è in antitesi di entrambi. Lo scenario attuale della produzione e circolazione delle immagini, particolarmente in Siria, sembra raccontarci di una dispersione, dissipazione e dissoluzione dei significati. In riposta a questo collasso, c’è però credo ancora una possibilità di interferenza, e di intervento, una risposta a queste forme di digital warfare e militarizzazione delle immagini.
Se è vero che la politica di testimonianza pubblica degli archivi digitali deve scontrarsi con la proliferazione di regimi visuali violenti e il fallimento dell’immagine-evidenza in favore dell’immagine indegna e non dignitosa, è nel lavoro con gli archivi, nella loro doppia intenzione, talvolta coincidente, di pratica documentaria ma anche creativa, che c’è una possibile strada per ridare operatività alle immagini, e ricostruire realtà e dimensioni di significato. Oggi, l’immagine della rivoluzione, già condannata all’estinzione perché forse lontana dai canoni di spreadability e di potenza riproduttiva, è sparita, insieme a chi questa rivoluzione l’ha tentata, cancellati virtualmente e fisicamente dalla sfera pubblica. Ma possiamo conservare una genuina, forse ingenua, credenza che negli interstizi ci sia una possibilità, come testimonia nonostante tutto questa forte politica attiva di resistenza contro l’uso mainstream delle immagini, guidato dal mercato dell’informazione e dall’ipertecnosocialità, e contro l’apparente irrefrenabilità delle immagini digitali di violenza, come per esempio il lavoro del collettivo di video-maker siriani Abounaddara ci racconta.
Certamente questo tipo di immagini altre e questi archivi operano in un circuito che viaggia ad un’altra velocità, forse non riuscendo ancora ad essere tanto effettivi quanto affettivi, o ad uscire dall’opacità, ma sono senza dubbio l’espressione dello sforzo di ricostruire i tasselli delle troppe “immagini mancanti”, e definire una nuova politica dell’immagine che strappi i soggetti a una visione voyeuristica, orientalista e compassionevole. Si tratta di un approccio vitale ed eticamente complesso, si tratta di scrivere una storia che si dispiega giorno per giorno, e di un modo per riportare quell’esplosione di energia scaturita con la rivoluzione nei diversi paesi, costruire una nuova temporalità, con le sue disgiunzioni e interruzioni, e con i suoi futuri possibili, tentando una reazione all’evacuazione del significato, e costruendo perciò un senso differente per questi nuovi archivi visuali e di memorie, per resistere alla vulnerabilità e all’obliterazione.
(Olga Solombrino)