“Alleeeeeertaaaaaaaaa… Alleeeeeeertaaaaaaaaaa…
Allerta transfensfemminista dalla sera alla mattina…”
Lo dovevo sapere che non era una buona idea insegnare questo slogan ai piccoli mostri di casa, ormai è un mese che ci svegliano sempre così. Oggi poi sono arrivat* saltando sul letto, non stanno nei panni per la partenza: partiamo con la s/family per il mare e loro stanno facendo le cose folli. Questo è il momento dell’anno più bello per loro, ma anche per noi, in cui riusciamo a prenderci del tempo fuori dalla routine e dalla quotidianità e stare tutt* insieme, compagn*, amich* amanti. Certo per noi non è sempre facile, abbiamo caratteri diversi e poi noi comunque siamo cresciut* in queste famiglie nucleari, gelosie, gerarchie dei rapporti, abbiamo avuto una socializzazione al lavoro di genere e degli affetti che probabilmente ci porteremo dietro per sempre… ma con loro mi sembra che stiamo facendo un buon lavoro. O forse loro con noi!
Abbiamo deciso di non smettere mai di raccontargli di quegli anni bui, come avevano fatto con noi le nostre nonne nel raccontarci la guerra; così stiamo provando noi a raccontare quanta fatica ci è costata resistere al fascismo. Forse sono ancora troppo giovani per capire cosa siano i confini… ma in realtà neanche io avevo mai capito cosa fossero. Ma devono saperlo che la gente moriva in mare, che si sparava per strada a chiunque fosse divers*; devono saperlo che la libertà che abbiamo oggi non ci è stata data, e che spetta a loro continuare a lottare lottare lottare per esser felici. Questo slogan poi a loro piace da morire, ma maledizione mo ci buttano giù dal letto con sta roba qui.
Andiamo a trovare le vecchie al mare. Le compagne che si erano cacate il cazzo di stare in città hanno fatto la domanda e hanno avuto ‘sta bella villa di questi ricconi di un tempo e vivono tutte insieme, chi zappa, chi prende il sole, chi cucina… certo ogni tanto attaccano la pippa, ma ai nostri mostrini piace sentire le storie di quando avevamo tutti un display nelle mani per fare qualunque cosa, pure per trovare la strada, fare i conti. E pure per scopare.
Forse in quegli anni mi sarei spaventata troppo a pensare di impiantarmi e fare impiantare alle persone che amo un chip sottocutaneo, ma il problema non era mica la tecnologia, era la società in cui vivevamo. Cazzo eravamo così razzisti, credo che abbiano molta più consapevolezza i mini di casa di cosa fosse stato il colonialismo che i miei coetanei nel 2018. E poi che vita di merda, sempre a lavorare lavorare lavorare, sempre senza una lira, sempre a fare i salti mortali. In quel momento ero incapace di immaginarmelo anche un mondo basato sullo scambio solidale, in cui avrei potuto prendermi il tempo per fare ricerca e dedicarmici con passione e tempi umani, perché era la mia esistenza a meritare reddito e non le ore o la quantità prodotta. No, ero proprio incapace di immaginarmi che potesse essere davvero così. Ad un certo punto avevo talmente smesso di crederci, che ormai mi sentivo pure in colpa di continuare a fare politica e pronunciare cose giuste, perché mi sembravano solo utopie naif ed ideologismi.
Io oggi le guardo e mi viene orrore solo a pensare che quando io avevo la loro età avevo il grembiulino bianco o rosa a scuola e che quella fosse quasi una liberazione rispetto a quando mi chiedevano “ma sei maschio o femmina?”. E giù di cascate di lacrime. Il più grande di loro ieri ha avuto le mestruazioni, grazie alla dea, perché non lo sopportavamo più così nervoso ed emotivo. Stasera ci ha chiesto di andare tuttu insieme al mare e fare il bagno con la luna piena. Spero che con gli anni impari a fare quello che non sono mai riuscita a fare io, ricordarmi che quella smania di suicidio che mi prendeva una volta al mese erano in realtà le mestruazioni. Ma credo che loro siano stat* abiutuat* sin da piccoli, anche con le persone adulte che si occupano della loro educazione, che sono parte di un ecosistema molto più complesso, in cui, per esempio, il tempo non è una convenzione lineare, ma l’accordo con il ciclo delle lune e il ritmo stagioni. Pensare che una volta dicevano che queste erano credenze da streghe, crune… janare. Invece guardando loro che si concepiscono come parte della natura sono riuscita a capire come siamo parte di un assemblaggio super-materialista con tutto quello che ci circonda. Insomma, io da quando ho il chip riesco a riconoscere come le mie capacità siano diventate incredibilmente post-umane, ma credo che non mi basterà tutta la vita che ho davanti per diventare superempatica come loro. Io mi fermo dove si ferma la tecnologia, le mie connessioni si limitano all’hub a cui sono connessa, loro vanno ben oltre il nostro hub, ben oltre il linguaggio della macchina, sentono ciò che cambia intorno a loro e loro stess* cambiano. E insomma lui dice che stasera c’è l’eclissi di luna piena, che si vedrà anche marte rosso, che il cielo sarà pieno di sangue e così pure lui e che nel mare potremo sentire tutti più forte questa cosa. Chissà lui cosa sente, ma io mi fido. Del resto ancora prima che nascesse mi chiedevo cosa sarebbe stato che non avrei capito delle persone che avrei messo al mondo. Ero terrorizzata che potessero essere razzisti, che fossero machisti, che volessero sposarsi in chiesa… militari… invece sono delle persone fantastiche e certo non potrò capire mai il loro materialismo, riderò di loro per sempre, e loro di me, perché sono così novecentesca in questa mia smania di controllo della natura e della tecnologia… io? Io? Vi rendete conto? Avrei dovuto saperlo che so…8 anni fa…
Ma tutt* possono sbagliare, tutt*, anche l’algoritmo sbaglia in continuazione, ma che libertà averlo scoperto, aver scoperto che la macchina sbaglia, come noi sbagliamo, che noi non possiamo controllare loro, che loro non possono controllare noi, ma che insieme, con tutto ciò che ci circonda, siamo meglio, ma ci vuole così tanto coraggio per lasciarsi andare, perché il cambiamento cambi noi.
Abbiamo sbagliato, continueremo a farlo, ma una sola cosa abbiamo fatto giusta: lottare. E continueremo a farlo, verso l’orizzonte delle utopie.
“Alleeeertaaaaaaaa…” Cazzo hanno ricominciato… vi prego possiamo abbandonare i mostri in autostrada? Vi prego!!!
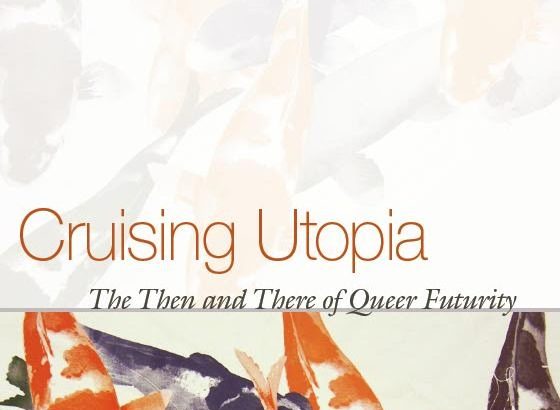

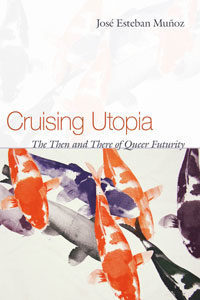 È dai tempi della scuola che ho imparato a confrontarmi con il fallimento. Il fallimento anche oggi arriva all’ultima fase. All’ultima frase. Facevo traduzioni perfette, forse non giuste, ma sempre appassionate; non era questione di grammatica e di studio, ma l’esercizio di cercare le parole giuste per dire le cose. Amavo scegliere le parole; ancora adesso. Brava: brava per i professori che mi premiavano con ottimi voti; brava per i compagni di classe che mi riconoscevano più la generosità del far copiare che una qualche dote; brava per i miei genitori che potevano raccontarmi come la figlia perfetta. Eppure tutto questo pesava su di me come un macigno: il peso delle aspettative. Non tanto quelle delle persone intorno a me, ma quelle di cui mi caricavo io stessa. Nata sotto il segno della Vergine, sempre in competizione con me stessa per essere all’altezza dell’ideale che mi pongo. L’ascendente in Pesci mi ha dotata del dono della creatività e la luna in Sagittario mi ha infuso l’arte della fuga. Ho iniziato molto presto a conseguire il fallimento come pratica militante di boicottaggio, e ho continuato con una certa perseveranza per il resto della mia vita. Una lunga carriera di esami a cui mi sono presentata senza aver studiato l’ultimo capitolo. L’esercizio del fallimento l’ho praticato con più dannazione che orgoglio, aggiungendo al peso delle aspettative l’ansia e i sensi di colpa.
È dai tempi della scuola che ho imparato a confrontarmi con il fallimento. Il fallimento anche oggi arriva all’ultima fase. All’ultima frase. Facevo traduzioni perfette, forse non giuste, ma sempre appassionate; non era questione di grammatica e di studio, ma l’esercizio di cercare le parole giuste per dire le cose. Amavo scegliere le parole; ancora adesso. Brava: brava per i professori che mi premiavano con ottimi voti; brava per i compagni di classe che mi riconoscevano più la generosità del far copiare che una qualche dote; brava per i miei genitori che potevano raccontarmi come la figlia perfetta. Eppure tutto questo pesava su di me come un macigno: il peso delle aspettative. Non tanto quelle delle persone intorno a me, ma quelle di cui mi caricavo io stessa. Nata sotto il segno della Vergine, sempre in competizione con me stessa per essere all’altezza dell’ideale che mi pongo. L’ascendente in Pesci mi ha dotata del dono della creatività e la luna in Sagittario mi ha infuso l’arte della fuga. Ho iniziato molto presto a conseguire il fallimento come pratica militante di boicottaggio, e ho continuato con una certa perseveranza per il resto della mia vita. Una lunga carriera di esami a cui mi sono presentata senza aver studiato l’ultimo capitolo. L’esercizio del fallimento l’ho praticato con più dannazione che orgoglio, aggiungendo al peso delle aspettative l’ansia e i sensi di colpa. Incandescent Illumination. Avevo scelto di non rileggerlo sebbene fosse il primo testo che avessi mai letto di questo autore che dopo mi ha tanto appassionata. Era agosto e mi preparavo per una summer school, lo aveva dato da leggere Jack Halberstam, entrambi grandi amici si sono molto influenzati nelle loro scritture. Sin da subito ho esorcizzato il pugno nello stomaco ricevuto da questo testo, scherzando con un mio amico sul destino di una dottoranda, costretta a leggere di uno che fa un salto fuori dalla finestra, mentre gli altri sono con le chiappe al mare. Questa volta me lo sarei risparmiata, infastidita dall’apologia di un suicidio in un testo che nasce dichiaratamente come risposta alle teorie nichiliste della svolta antisociale del pensiero queer. Cosa cazzo c’entra il suicidio mentre parliamo di utopia, speranze, relazioni guardando al futuro?
Incandescent Illumination. Avevo scelto di non rileggerlo sebbene fosse il primo testo che avessi mai letto di questo autore che dopo mi ha tanto appassionata. Era agosto e mi preparavo per una summer school, lo aveva dato da leggere Jack Halberstam, entrambi grandi amici si sono molto influenzati nelle loro scritture. Sin da subito ho esorcizzato il pugno nello stomaco ricevuto da questo testo, scherzando con un mio amico sul destino di una dottoranda, costretta a leggere di uno che fa un salto fuori dalla finestra, mentre gli altri sono con le chiappe al mare. Questa volta me lo sarei risparmiata, infastidita dall’apologia di un suicidio in un testo che nasce dichiaratamente come risposta alle teorie nichiliste della svolta antisociale del pensiero queer. Cosa cazzo c’entra il suicidio mentre parliamo di utopia, speranze, relazioni guardando al futuro? Muñoz analizza il fallimento accanto al virtuosismo, poiché nella sua stessa matrice c’è la potenzialità: quello che poteva essere e non è stato; quello che ancora un giorno potrà essere… incluso un nuovo fallimento!
Muñoz analizza il fallimento accanto al virtuosismo, poiché nella sua stessa matrice c’è la potenzialità: quello che poteva essere e non è stato; quello che ancora un giorno potrà essere… incluso un nuovo fallimento!


