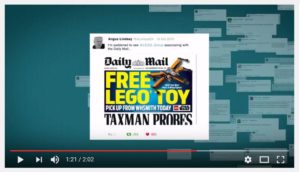(Cover: Fabrice – Muiderpoort Station, Amsterdam 2010, detail. Photo: Giulia May)
In un presente distopico marcato da isolamento fisico, le piattaforme digitali stanno acquisendo un ruolo ancora piu’ centrale nelle nostra vita sociale e privata. Ci fanno essere vicini ai nostri cari, trovare informazioni (utili o meno), ripensare le connessioni lavorative, trovare corsi di yoga online, comprare cose e condividere contenuti emozionanti o ansiogeni – in breve ci fanno essere parte di un sistema interconnesso di comunita’ vicine e lontane.
Se le conseguenze sociali, culturali e psicologiche di questi nuove dinamiche di interazione con i media digitali sono ancora da vedersi, appena prima dell’inizio dell’era della pandemia una serie di studi stavano cercando invece di misurare l’impatto delle piattaforme digitali sulla partecipazione politica. L’ultimo numero del 2019 dell’International Communication Journal, con una sezione speciale dedicata alle piattaforme politiche in Europa, sembra l’occasione ideale per cercare di riprendere qualcuna delle domande sospese sulle piattaforme digitali e il loro uso politico – mentre cerchiamo di processare altri usi in versione amplificata dal nostro isolamento iperconnesso.
Curato da Marco Deseriis e Davide Vittori, lo speciale include sei casi studio sull’uso delle piattaforme digitali in diversi contesti europei e da parte di vari attori politici. Se il filo comune è come ogni piattaforma renda possibile delle forme di partecipazione politica, una domanda centrale rimane latente e inespressa: chi sono le persone che usano queste piattaforme digitali, come le usano e perché’ in questi studi non hanno quasi mai voce?
1. Le piattaforme digitali nel “lungo decennio”
Piattaforme sociali e/o piattaforme politiche. Il lungo decennio, come Deseriis e Vittori chiamano quello che si è appena chiuso, è stato dominato da movimenti anti-autoritari e anti-austerità che hanno incorporato l’uso dei social media in maniere nuove e dirompenti. Se la logica dei social network commerciali può avere facilitato i movimenti nella loro fase iniziale, si è rivelata presto meno adatta a sostenere strategie a lungo termine (van Dijck & Poell, 2013). Per questo diversi gruppi hanno cominciato a orientarsi verso strumenti specializzati (e software open-source) per supportare i loro processi decisionali. Deseriis e Vittori insistono che gli elementi comuni a social media platforms (SMPs) e digital democracy platforms (DDPs) rimangono più importanti delle differenze, nonostante queste siano significative. Da una parte le SMPs, nate per estrarre profitto da dati personali e informazioni condivise, che però data l’ampia base di utenti hanno contribuito a rivitalizzare l’azione politica. Dall’altra le DDPs, fatte per essere di supporto a processi di partecipazione e deliberazione, ma di fatto spesso limitate nel loro impatto e raggio di azione.
Come influisce la logica algoritmica sulla partecipazione? Un tema importante nei dibattiti recenti è stato quello sulla ‘logica algoritmica’ dei social media, e quanto questa condizioni l’agency politica degli utenti. C’è chi sostiene che la logica algoritmica, che ha sostituito la logica editoriale dei media analogici, condizioni la partecipazione in maniera più sottile e pervasiva (e.g van Dijk & Hacker, 2018). Altri enfatizzano invece la creatività e ingegnosità degli utenti, dimostrando come si possa giocare con le funzionalità di ogni piattaforma e aggirarne i limiti (e.g. Clark et al., 2014). Un’altra autrice che contribuisce allo speciale, Maria Bakardjieva, conclude che “la partecipazione dei cittadini… non può essere ridotta alla sola architettura delle piattaforme, ma ne è sicuramente influenzata”. Quello che fa la differenza, sostiene Bakardjieva, è “chi partecipa? A cosa? Per quale scopo?”.

2. Gli utenti delle piattaforme istituzionali
Una piattaforma può rafforzare i membri di un partito? Deseriis e Vittori cercano di valutare l’impatto delle piattaforme usate da Podemos e da 5 Stelle, rispettivamente Participa e Rousseau, sulla democrazia interna dei due partiti e gli squilibri di potere. Entrambi i partiti hanno un forte “orientamento tecno-populista” (Deseriis, 2017), ma allo stesso tempo sono caratterizzati da traiettorie politiche e ideologiche profondamente diverse, riflesse anche da modelli organizzativi divergenti: una varietà di nodi decisionali centralizzati e decentralizzati (Podemos) contro un modello senza alcun intermediario tra vertici e membri di partito (5 Stelle). Deseriis e Vittori sostengono che, nonostante queste distinzioni, in entrambi i casi le funzionalità delle piattaforme sono utilizzate in maniera molto selettiva, per confermare soprattutto decisioni già prese dai vertici di partito. Questa potrebbe essere una delle ragioni del netto declino dei partecipanti al voto che entrambe le piattaforme hanno registrato dopo il primo anno di vita. Altre possibili ragioni includono l’abbandono dei primi iscritti, o il fatto che ai membri viene richiesto di votare troppo frequentemente, o – nel caso di Rousseau – che agli utenti non vengono offerte altre prospettive se non quelle dei vertici quando si tratta di votare su argomenti controversi. Di certo per confermare queste ipotesi ci vorrebbero nuovi studi, che dovrebbero includere anche gli utenti di entrambe le piattaforme.
Una piattaforma può mantenere alta la qualità del dibattito nel tempo? Guardando solo a quello che succede sui social media verrebbe da rispondere no, ma anche le amministrazioni locali in Europa hanno cercato di rimodellare la partecipazione e deliberazione online. Nel loro studio su Decidim, la piattaforma che permette ai cittadini di Barcellona di contribuire al piano strategico della città, Borge Bravo, Balcells e Padró-Solanet analizzano la “qualità deliberativa” del dibattito su turismo e ospitalità. Dalla loro analisi il tempo risulta essere un fattore chiave, nelle varie fasi che attraversano le conversazioni su piattaforme come Decidim. Se all’inizio la maggior parte degli utenti cerca di costruire argomenti persuasivi e razionali, con l’avanzare della discussione arriva invece spesso anche un impoverimento della qualità del dibattito. Questo a sua volta può fare si che nuovi utenti siano meno interessati a prendere parte e abbassa la soglia degli argomenti accettabili, mentre i pochi utenti rimasti trasformano il dibattito in scontro personale. La loro conclusione è che una deliberazione spontanea online è possibile, ma la difficoltà maggiore è riuscire a mantenere la qualità di questa deliberazione nel tempo.
Dove sono posizionati gli utenti delle piattaforme governative? Come sostiene Bakardjieva, dipende molto da chi crea la piattaforma, chi la usa e quali strategie si adottano per cercare di influenzare chi governa. Il suo studio compara tre soluzioni in uso nella città bulgara di Stara Zagora: una piattaforma governativa, una collaborativa creata dai cittadini, e una pagina Facebook. La piattaforma governativa, voluta dalla municipalità, può essere usata dai cittadini per riportare guasti o problemi e richiedere documenti. Come in altri casi simili, gli utenti di questa piattaforma sono posizionati come clienti. A fare la differenza nel caso della piattaforma collaborativa è il fatto che questa sia stata concepita e disegnata dai cittadini. Attraverso una serie di interviste con il nucleo dei fondatori, Bakardjieva descrive come gli utenti di questa piattaforma non siano solo messi nella condizione di segnalare un problema, ma anche di ricevere una risposta. Caso per caso, la piattaforma collettiva ha infatti costruito nel tempo un suo potere di negoziazione ed è ora riconosciuta dagli amministratori come interlocutore politico pur mantenendo una forte autonomia.

3. Gli utenti delle piattaforme commerciali
Basta una piattaforma per promuovere la partecipazione? Bakardjieva offre anche un esempio da manuale su come ogni piattaforma possa assecondare diversi scopi. Quando un altro gruppo a Stara Zagora inizia a mobilitarsi per salvare un parco locale da piani di sviluppo edilizio, diventa chiaro che la disputa necessita di strumenti diversi da quelli utilizzati per la cooperazione, e gli attivisti li trovano in Facebook, piattaforma multifunzione. A questo gruppo infatti Facebook offre un apparato di comunicazione generalista che viene capito e usato abilmente dal gruppo di cittadini. Allo stesso tempo, Bakardjieva ammette che una partecipazione efficace non può essere costruita solo attraverso Facebook o nessun’altra piattaforma. Nel caso del parco, il supporto offerto da altri gruppi e media si rivela infatti cruciale per mobilitare numeri più consistenti della popolazione. In generale, come si sostiene dall’inizio dello scorso decennio con l’idea di media convergence e approcci simili, è essenziale continuare a considerare come le piattaforme digitali si collegano (e sovrappongono) con altre forme mediatiche e di mobilitazione.
Può una piattaforma mettere insieme partecipazione e rappresentazione? In un altro contributo allo speciale Louise Knops e Eline Severs presentano il caso della Piattaforma dei Cittadini per il Supporto ai Rifugiati (CPRS), una pagina Facebook creata in Belgio in risposta alla crisi del 2014-2015 per coordinare assistenza e logistica. Lo studio guarda a come nel corso degli anni CPRS abbia assunto sempre più un ruolo di portavoce politico dei belgi che supportano politiche di immigrazione più inclusive e accoglienti. Questa prospettiva rinforza studi precedenti che hanno sostenuto che le reti sociali online possano trovare un compromesso tra la logica della partecipazione e la logica della rappresentazione (Gerbaudo, 2017). Altro aspetto interessante dell’articolo è l’enfasi sul ruolo centrale giocato dall’amministratore della pagina del CPRS, che quotidianamente si occupa di filtrare e selezionare i contenuti pubblicati e condivisi dai membri della pagina, cosa che ricorda come la “logica editoriale” molto spesso coesista con la “logica algoritmica” e non sempre in ruolo subordinato. Ancora una volta, come ammettono le autrici, nuovi studi con più utenti sarebbero necessari per confermare questi risultati.
Può una piattaforma combinare partecipazione e apprendimento sociale? Dan Mercea e Helton Levy esplorano la relazione tra questi due fenomeni su Twitter, guardando a un insieme di retweets della “People’s Assembly” britannica tra il 2015 e il 2016. La Network Theory finora sembra avere interpretato l’apprendimento sociale come un processo che include diffusione e validazione da parte degli utenti, che in Twitter corrisponde ai retweet. Allo stesso tempo, come notano Mercea e Levy, i retweet possono anche essere visti come una forma di “cura” della conoscenza collettiva, facendo da filtro a rumore e informazioni non rilevanti. Nel caso della People’s Assembly, i retweet infatti sembrano avere contributo a distribuire e rendere evidente la conoscenza delle ragioni che portano diversi attori a cooperare nell’Assembly, mantenendo allo stesso tempo un insieme di risorse comuni sul movimento. Lo studio è basato su un’analisi quantitativa dei retweets e su un piccolo numero di interviste con utenti di Twitter che – suggeriscono anche in questi caso gli autori – andrebbe ampliato per potere raggiungere delle conclusioni più generali.

4. L’utente-bersaglio: non è altro che propaganda
Perché le piattaforme online facilitano le campagne reazionarie? Se questo numero speciale guarda soprattutto ai successi della partecipazione digitale o ai suoi possibili ostacoli, altri studi recenti si sono dedicati invece a esplorare quello che qualcuno chiamerebbe il lato oscuro delle piattaforme. Dopotutto Brexit è andata come è andata, e altre campagne reazionarie hanno raccolto un discreto successo in Europa e altrove. Uno degli elementi che spiegano l’inaspettata popolarità delle piattaforme digitali per i partiti di estrema destra è la loro dinamica di partecipazione, che secondo Gregory Asmolov (2019) crea condizioni ideali per una “propaganda partecipativa”. Il concetto stesso di propaganda, per quanto digitalizzato, rimane certamente problematico nel suo rimandare a dibattiti vecchi e fortunatamente superati sugli “effetti” dei media sulla mobilitazione. Allo stesso tempo, Asmolov e LeJeune sostengono che il risultato di una manipolazione informativa che coinvolge gli utenti non è necessariamente la mobilitazione: in diversi casi – basti pensare a Cambridge Analytica o Breitbart – l’obiettivo è piuttosto il disorientamento politico e la frammentazione sociale.
Non siamo che bersagli di bots e trolls? A partire dal 2015 il progetto Computational Propaganda (basato all’Oxford Internet Institute) ha investigato l’assemblaggio di algoritmi di social media, agenti autonomi e big data coinvolti nella manipolazione dell’informazione. Il loro ultimo report su “Global disinformation order” (2019) sostiene che negli ultimi due l’investimento in questo campo ha visto una crescita del 150% anni in tutto il mondo – paesi liberali e autoritari, occidentali e non-occidentali. Le nuove “cyber troops” operano attraverso bots, accounts umani, automatizzati o rubati; lavorano per screditare l’opposizione politica e isolare il dissenso. Nonostante l’abbondanza di alternative, Facebook sembra rimanere la piattaforma prescelta non solo per la scala globale della sua copertura, ma anche per le sue componenti: le strette connessioni personali che la compongono, l’incorporazione di notizie politiche, la capacità di ospitare gruppi e pagine.
A rimanere chiaramente fuori da questa cornice è il significato che le persone danno alle informazioni trovate sulle piattaforme. E se da una parte ci si aspetta che studi di comunicazione politica e sociologia politica siano improntati sull’idea dell’utente-bersaglio, anche tra i teorici dei nuovi media sembrano guadagnare popolarità le visioni apocalittiche di sistemi invisibili, oppressivi e ingannevoli, dove i trolls hanno la capacità di stravolgere i nostri pensieri e i nostri comportamenti (Lovink 2020).

5. Conclusioni – Stuart Hall e la piattaforma-pensiero
Piattaforme come punto di incontro. Cosa ci rimane quindi? Come Emiliana De Blasio e Michele Sorice sostengono in un altro articolo contenuto nello speciale, uno dei pochi punti non controversi è che l’idea di “piattaforma” si è ormai affermata come punto di incontro tra prospettive molto diverse. Inaspettatamente, alla fine del loro tour de force enciclopedico su tutta la possibile letteratura scientifica prodotta finora sulla partecipazione, De Blasio e Sorice invocano Stuart Hall e la sua ineguagliata capacità di combinare metodi e strumenti della sociologia politica con media studies e analisi di culture alternative. Questa prospettiva multimodale, criticamente solida, è precisamente quello che sembra mancare a molta teoria contemporanea sui media, che può essere al meglio affascinante ma spesso risulta inaccessibile e/o politicamente sterile.
Piattaforme in tempi di crisi. Fin dalle prime misure di emergenza per il Covid-19 in Asia e Europa, le piattaforme commerciali hanno mostrato il meglio e il peggio della condivisione e costruzione di connessioni. I social network sono portatori di disinformazione, notizie false e palcoscenico per le esibizioni di improbabili esperti o narcisisti professionisti. Allo stesso tempo una crisi di questa portata apre a un possibile reset sociale e tecnologico, al quale le piattaforme digitali potrebbero contribuire con informazioni utili al supporto delle comunita’, per trovare soluzioni a problemi condivisi e per redistribuire risorse. Se e’ ancora presto per vedere uno sviluppo di piattaforme non commerciali e ad-hoc, una direzione possibile e’ indicata iniziative immediate/precoci come gruppi, pagine o wikis costruite per mettere insieme e coordinare sforzi di solidarieta’ locali e globali.
Utenti prescritti e utenti mancanti. Il suggerimento più utile di tutto lo speciale viene probabilmente ancora una volta da Bakardjieva, che prende da de Certeau (1984) la visione delle piattaforme come “insiemi di possibilità e interdizioni”, caratterizzate tra le altre cose dai loro utenti “prescritti” (Latour, 1992) e dagli usi anticipati e manifesti che questi ne possono fare. Mettere a confronto diversi tipi di piattaforme, come fa Bakardjieva nel suo studio, è anche un approccio fondamentale per capire meglio la varietà di posizioni che le piattaforme creano per i loro utenti. L’unico pezzo mancante dal quadro è ancora una volta quello degli utenti: c’è bisogno di includere di più e meglio le loro voci per capire cosa fanno di queste piattaforme costruite per (e contro di) loro, in tempi ordinari e straordinari.