 “Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (1972, trad. it. 2015), per evidenziare come la “sostanziale apparenza” del femminile nella tradizione figurativa occidentale incidesse sui modi in cui le donne facevano esperienza di sé prima di tutto in quanto rappresentazioni. Una condizione di immaginità sostanziale [to-be-looked-at-ness] denunciata qualche anno dopo da Laura Mulvey (1975) quale strategia per precludere allo sguardo femminile l’accesso all’esperienza attiva e al piacere della visione. Le prospettive molteplici offerte della produzione televisiva contemporanea mostrano fortunatamente che la rappresentazione malestream, cioè quella che inchiodava l’oggetto-donna alla fissità dello stereotipo (come mancanza o come eccesso), ha finalmente lasciato spazio a una pluralità di punti di vista. A partire da questa considerazione, in Zapping di una femminista seriale (Ledizioni, 2018), Federica Fabbiani si addentra nel mondo delle personagge seriali tracciando una provvisoria cartografia in cui si domanda non solo se esista una trama femminista nella serialità, ma soprattutto se sia possibile, o piuttosto se e in che termini abbia senso, cercare uno sguardo femminile come possibile alternativa allo sguardo maschile.
“Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (1972, trad. it. 2015), per evidenziare come la “sostanziale apparenza” del femminile nella tradizione figurativa occidentale incidesse sui modi in cui le donne facevano esperienza di sé prima di tutto in quanto rappresentazioni. Una condizione di immaginità sostanziale [to-be-looked-at-ness] denunciata qualche anno dopo da Laura Mulvey (1975) quale strategia per precludere allo sguardo femminile l’accesso all’esperienza attiva e al piacere della visione. Le prospettive molteplici offerte della produzione televisiva contemporanea mostrano fortunatamente che la rappresentazione malestream, cioè quella che inchiodava l’oggetto-donna alla fissità dello stereotipo (come mancanza o come eccesso), ha finalmente lasciato spazio a una pluralità di punti di vista. A partire da questa considerazione, in Zapping di una femminista seriale (Ledizioni, 2018), Federica Fabbiani si addentra nel mondo delle personagge seriali tracciando una provvisoria cartografia in cui si domanda non solo se esista una trama femminista nella serialità, ma soprattutto se sia possibile, o piuttosto se e in che termini abbia senso, cercare uno sguardo femminile come possibile alternativa allo sguardo maschile.
Sex and the City è stata la prima serie televisiva a sdoganare il desiderio femminile e la ricerca di empowerment delle sue protagoniste, ma anche a circoscrivere tutto questo entro il recinto di un esasperato materialismo bianco e alto-borghese certamente non rivoluzionario sul piano sociale. Quali strade ha percorso Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker) tra uno stiletto Manolo Blahnik e una balconette effetto supervolume come quello che indossa oggi, trascorsi vent’anni, nel revival-spot di Intimissimi? Cosa significa quando dice che è riuscita ad avere successo “senza cambiare mai”? Si tratta ancora della stessa scena? E dove si colloca la spettatrice quando il personaggio afferma di vestire “semplicemente i propri panni”,[1] adesso solo un po’ più cheap che chic? Insomma, si chiede Fabbiani, possiamo davvero archiviare Carrie Bradshaw?
Indubbiamente stiamo assistendo a un re-styling di quel femminismo pop che la studiosa Angela McRobbie individuava negli anni Novanta: un femminismo mediatizzato veicolato da slogan che, strizzando l’occhio alla società dei consumi, sarebbe evoluto nell’individualismo depoliticizzato del postfemminismo. Oggi, da una parte c’è Chiara Ferragni che sceglie di sposarsi in Dior perché la direttrice della maison, Maria Grazia Chiuri, “ha portato un’allure completamente diversa al marchio per comunicare un messaggio sul nuovo ruolo delle donne, sul femminismo”: facendo, per esempio, sfilare in passerella modelle in t-shirt (poco importa quanto costose e quanto poco pagate alla manodopera) con scritte come “We should all be feminism”, o “Why have there been no great women artists”[2]. Dall’altra, in varie parti del mondo le donne manifestano contro le restrizioni alle leggi sull’aborto vestite col mantello rosso e la cuffia bianca come Difred, la protagonista de “Il racconto dell’ancella”, serie di successo tratta dall’omonimo libro di Margaret Atwood di cui si è già parlato qui e la cui storia presenta non poche analogie con l’involuzione del nostro presente.
E tuttavia viene da chiedersi: è sufficiente indossare le orecchie rosa di un femminismo ad alto tasso di iconicità, che troppo spesso però invisibilizza il proprio passato – nel libro di Atwood rappresentati dalla relazione di Difred con la madre, per nulla sviluppata nella trasposizione televisiva – e riduce la militanza a una rivendicazione dei “diritti umani” fondamentali? Che ne è stato della messa in guardia verso le politiche dell’inclusione, quelle forme subdole di “sopraffazione legalizzata” rappresentate dal femminismo dell’uguaglianza denunciato da Carla Lonzi, che Fabbiani giustamente ricorda?
 Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.
Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.
Capita spesso, nota Fabbiani, che il modo in cui questi temi trovano sviluppo sia come “smussato” edulcorando o tralasciando i fatti e privato della dimensione più politica delle parole e delle azioni femministe, che prevalga il tono intimistico o una prospettiva individualistica, che i personaggi femminili s’incontrino senza riuscire a dar vita a una dimensione davvero collettiva, e che quelli maschili siano più accondiscendenti ed evanescenti di fronte alle rivendicazioni delle personagge di quanto non accada nella realtà. Ma capita anche che la sessualità e il piacere femminile (cisgender e non) acquistino espressione e visibilità, che la maternità sia vista in tutta la sua problematicità e polivalenza, che la fragilità e la paura di non essere all’altezza non siano più difetti da nascondere né tantomeno vezzi momentanei, che la meta non sia l’integrazione, e che le conquiste di alcune siano mostrate accanto all’esclusione di altre.
Sempre attenta a mettere in rilievo l’eterogeneità e le ambiguità della televisione seriale che prende in esame, Fabbiani non racconta soltanto le storie di ciò che ha visto ma, come è proprio della cartografia femminista, anche lei stessa che guarda e dichiara la propria ottica posizionata (e per questo sempre mobile), non a caso presente già nel titolo del libro. In quanto spettattrice lesbica e femminista, che non si sente pienamente a proprio agio nella logica ancora binaria del female gaze, Fabbiani dialoga con la sua interlocutrice interrogandola e interrogandosi, senza imporre mai la propria ottica, semmai esponendola, come la protagonista di Fleabag (serie del 2016) quando rivolta in camera interpella la spettatrice, dandoci delle parole e delle immagini il suo personale vissuto. “Il femminismo” infatti, scrive Fabbiani, non è mai solo storia, ma “lente di osservazione attraverso cui passare in rassegna scontri e negoziazioni, vittorie e sconfitte, decessi e resurrezioni”.
Esiste, dunque, uno sguardo femminile? No, se come tale si intende un modo di guardare riconducibile al sesso biologico. Esiste uno sguardo di genere? Sì, nella misura in cui lo si intenda come la prospettiva dei corpi diversamente posizionati rispetto alle norme che ne producono e regolano l’identità. Esiste uno sguardo femminista? Sì, se questa prospettiva si trasforma in assunzione consapevole di un posizionamento resistente, che interferisce con la rappresentazione e la complica, piuttosto che rivelarne un senso unico.
È quello che accade guardando attraverso il caleidoscopio di Transparent (la cui trasparenza è infatti tutt’altro che tale), la serie di Jill Soloway, di cui esistono al momento quattro stagioni (2014-2017), in cui attorno alla transizione del genitore Maura Pfefferman si muovono le identità e le relazioni fluide dei tre figli Ali, Sarah e Josh, mentre la differenza sessuale diventa solo uno dei modi possibili per attraversare i confini che separano o uniscono variamente i personaggi, diversi per genere, educazione, classe, etnia, fede religiosa. Con Transparent, forse davvero per la prima volta sul piccolo schermo, trova spazio uno sguardo femminista non limitato alla sola questione del genere, ma attento alle intersezioni molteplici dell’oppressione – e ai suoi posizionamenti mai lineari – grazie a una rappresentazione schietta, al contempo caustica e toccante, in grado di consentire un’identificazione vivibile[3] fra personagge e spettatrici, anche perché effettivamente radicata nel vissuto della regista (il cui padre è adombrato in Maura). Transparent mostra che per far apparire il non rappresentabile – ciò che eccede la logica stessa della rappresentazione – all’interno del rappresentato è necessario opacizzare e ispessire il senso, incarnarlo nei corpi non più sottoposti alla dialettica di esclusione/inclusione, nascondimento/rivelazione, ma complicati in grovigli di differenze.

Se esiste un femminismo nella serialità televisiva, allora, questo va cercato piuttosto sul piano del guardare che su quello del guardato. Come (da dove) e non solo cosa guardiamo è fondamentale per vedersi ed essere in grado di vedere le relazioni femministe all’interno di una stessa narrazione o fra storie diverse: “Ognuna a suo modo ricodifica le varie forme della narrazione per trarne una personale interpretazione”, scrive Fabbiani, un’interpretazione che tocca da vicino il vissuto anche perché, tra l’altro, a consentirlo è la modalità stessa, affettivo-ossessiva, di fruizione delle puntate (come nella pratica immersiva del bingewatching, un’overdose di serialità ininterrotta consentita dal rilascio di tutte le puntate di una stagione in contemporanea). Ma il luogo da dove guardiamo non è fisso, è un luogo che cambia, che si apre, che mette a rischio le proprie conquiste. Muovendoci tra il reale e l’immaginario, abbiamo capito che non c’è nessuna immaginità sostanziale perché non c’è nessuna realtà sostanziale del femminile, nessuna complementarietà da colmare o uguaglianza da rivendicare. Se ogni ottica è una politica del posizionamento, è in movimento che dobbiamo guardare per smettere di dovere continuamente, soltanto, vedere noi stesse.
[1] Questa e la citazione precedente sono tratte dallo script della pubblicità della nuova campagna Intimissimi – linkata in testo – interpretata da Sarah Jessica Parker/Carrie.
[2] La prima frase è tratta da una talk (2012) della scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie (inserita anche da Beyonce in Flawless); la seconda è il titolo di un noto saggio (1971) della storica dell’arte Linda Nochlin. Peccato però che, in quella talk, Adichie sostenga anche che “è impossibile parlare della storia singola senza parlare del potere […] Come sono raccontate, chi le racconta, quando vengono raccontate, quante se ne raccontano, tutto questo dipende dal potere. Il potere è la possibilità non solo di raccontare la storia di un’altra persona, ma di renderla la storia finale di quella persona”. E che quella di Nochlin, a detta della stessa autrice, sia la meno femminista delle domande possibili, un tranello teso a chi non ha compreso che già il fatto stesso di porre una simile domanda significa non capire che il problema sta proprio nelle domande poste, e nelle risposte che queste condizionano.
[3] A tale punto la finzione si mescola al reale che Jeffrey Tambor (Maura) ha lasciato il cast perché accusato di molestie sessuali dall’attrice Trace Lysette (Davina sullo schermo).

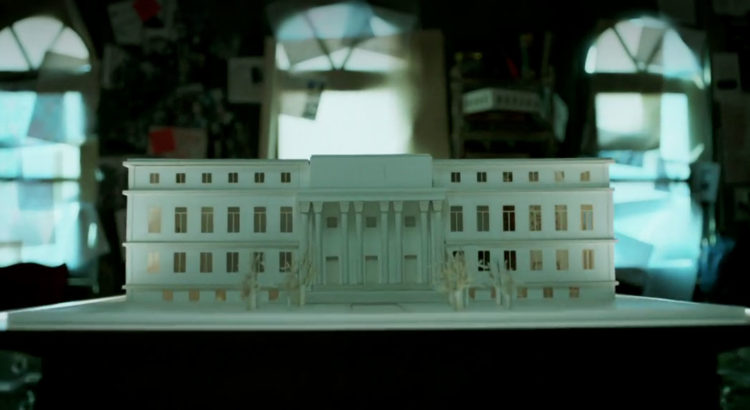

 O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…
O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…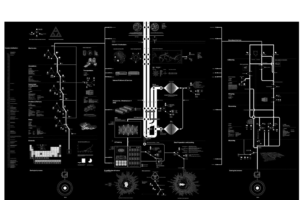

 Tutto questo nella serie, purtroppo, scompare: da una parte, Difred è progressivamente trasformata in un’eroina dall’ego forte in un crescendo di azioni che ne risaltano la volontà di ribellione, come già era accaduto nel film. Sullo schermo, cosa per nulla secondaria, Difred si chiama June
Tutto questo nella serie, purtroppo, scompare: da una parte, Difred è progressivamente trasformata in un’eroina dall’ego forte in un crescendo di azioni che ne risaltano la volontà di ribellione, come già era accaduto nel film. Sullo schermo, cosa per nulla secondaria, Difred si chiama June





 Difred vede tutti quelli intorno a sé come sagome: Serena Joy, la moglie del Comandante, le sembra un’etichetta di prodotti per capelli, il Comandante un’acquaforte di propaganda, Luke, il marito da cui con la figlia è stata forzatamente separata tentando la fuga da Galaad, una litografia pubblicitaria, le altre ancelle una fantasia di pastorelle olandesi su una tappezzeria; persino Nick, la Guardia personale del Comandante con cui Difred ha una relazione, è descritto come un idolo di cartone. In questo susseguirsi di quadri sempre uguali si staglia anche la silhouette rossa di Difred, che di sé ci fornisce pochissimi tratti, e che – ma solo nel libro – non ci rivela mai il suo nome: chiusa dentro una stanza-cella dove assiste alla vita da una finestra, Difred non riesce a ricordare com’è lei vista da fuori, ormai spossessata della propria identità dallo sguardo costante degli Occhi – le spie di regime disseminate dappertutto.
Difred vede tutti quelli intorno a sé come sagome: Serena Joy, la moglie del Comandante, le sembra un’etichetta di prodotti per capelli, il Comandante un’acquaforte di propaganda, Luke, il marito da cui con la figlia è stata forzatamente separata tentando la fuga da Galaad, una litografia pubblicitaria, le altre ancelle una fantasia di pastorelle olandesi su una tappezzeria; persino Nick, la Guardia personale del Comandante con cui Difred ha una relazione, è descritto come un idolo di cartone. In questo susseguirsi di quadri sempre uguali si staglia anche la silhouette rossa di Difred, che di sé ci fornisce pochissimi tratti, e che – ma solo nel libro – non ci rivela mai il suo nome: chiusa dentro una stanza-cella dove assiste alla vita da una finestra, Difred non riesce a ricordare com’è lei vista da fuori, ormai spossessata della propria identità dallo sguardo costante degli Occhi – le spie di regime disseminate dappertutto.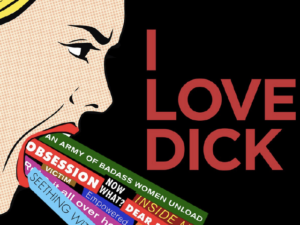 è un miscuglio di romanzo epistolare, memoir, critica d’arte, pamphlet politico, scritto quasi interamente in prima persona, che prende avvio da una cena di lavoro in cui Chris-personaggio, come nella vita al fianco del marito accademico Sylvère in qualità di “moglie di” (nonostante abbia già scritto diversi testi e combatta per il suo riconoscimento come cineasta sperimentale), conosce Dick e se ne infatua all’istante. Nel libro, Dick è un professore universitario in cui si è riconosciuto, prendendone subito le distanze, il sociologo e mediologo Dick Hebdige, che sullo schermo diventa invece un artista minimalista (interpretato da Kevin Bacon) ispirato a Donald Judd
è un miscuglio di romanzo epistolare, memoir, critica d’arte, pamphlet politico, scritto quasi interamente in prima persona, che prende avvio da una cena di lavoro in cui Chris-personaggio, come nella vita al fianco del marito accademico Sylvère in qualità di “moglie di” (nonostante abbia già scritto diversi testi e combatta per il suo riconoscimento come cineasta sperimentale), conosce Dick e se ne infatua all’istante. Nel libro, Dick è un professore universitario in cui si è riconosciuto, prendendone subito le distanze, il sociologo e mediologo Dick Hebdige, che sullo schermo diventa invece un artista minimalista (interpretato da Kevin Bacon) ispirato a Donald Judd




