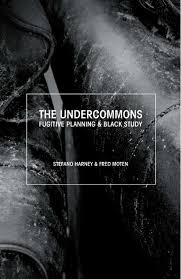immagine in evidenza (geralt at Pixabay)
(Tratto da una lezione del corso di Teorie dei Media Digitali, Lauree Magistrali in Lingue e comunicazione interculturale in area euromediterranea; Europa e Americhe; Asia e Africa, Università di Napoli, L’Orientale)
Il saggio di Neda Atanasoski e Kalindi Vora Surrogate Humanity: Race, Robots and the Politics of Technological Futures. (pubblicato dalla Duke University Press, 2019 come parte della serie Perverse Modernities, curata da Jack Halberstam and Lisa Lowe) inizia con due vignette, una pubblicata sulla copertina della rivista Mother Jones (iconica rivista della sinistra radicale americana), e un’altra sulla copertina del New Yorker (storica rivista della sinistra liberale americana). Entrambe risalgono al 2017 durante uno degli ormai ricorrenti dibattiti sulla minaccia costituita dalla rivoluzione robotica e dall’intelligenza artificiale al lavoro umano.
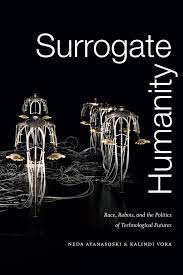
La prima vignetta è una variazione sulla famosissima foto del 1932 “Pranzo sul Grattacielo”, scattata nel periodo della Grande Depressione quando la disoccupazione negli Stati Uniti era al 50%, quella per intenderci che ritrae un gruppo di operai che pranzano seduti sulla putrella di un grande grattacielo in costruzione. Al posto degli operai umani però nella vignetta di Mother Jones ci sono i robots che condividono il pranzo con un singolo solitario lavoratore umano. La seconda è una copertina del New Yorker che rappresenta un giovane maschio bianco in evidente tenuta da senza tetto che seduto a terra chiede l’elemosina ad una folla di passanti-robot, che invece lo ignorano superandolo con le loro borse dello shopping mentre controllano i loro smart phones.
Queste due copertine sono esemplificative di una proliferazione di discorsi sulla rivoluzione robotica e dell’Intelligenza Artificiale, e in particolar modo della reazione da parte delle sinistre nei paesi del Nord globale. Le due vignette riprendono un ritornello familiare: i robots (o adesso l’Intelligenza Artificiale) sostituiranno il lavoro umano, non solo quello manuale, ma anche altri tipi di lavoro (avvocati, medici, giudici, notai, e adesso anche giornalisti, educatrici, e artist*) che sembravano essere immuni dalle precedenti ondate di automazione.
I robots e le IA, dunque, libereranno gli umani dal lavoro meccanico e ripetitivo, permettendo loro di riservare a sé quello più creativo, oppure diventeranno i nuovi padroni del mondo? Oppure, come sostengono gli articoli che accompagnano le vignette di cui sopra, è solo che l’automazione senza distribuzione dei ‘frutti del lavoro robotico’ creerà disoccupazione e povertà di massa? E perché la disoccupazione e povertà di massa sono rappresentati come il risultato di una “sostituzione robotica”, dove “loro” (i robots) dopo essersi sostituiti agli umani diventano padroni riducendoli in povertà “a casa nostra”?
Nella produzione di discorsi e immaginario attorno a robots e intelligenza artificiale, dicono Atanasoski e Vori, la domanda sulla questione della sostituzione robotica del lavoro umano è una che proviene da un soggetto del lavoro che si qualifica come universale, ma che è in pratica codificato come bianco e maschio.
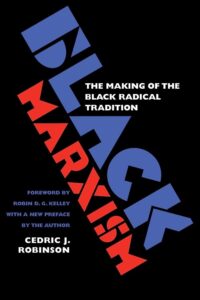 In realtà, come sottolineano le autrici, l’automazione del lavoro fino ad ora ha colpito e sostituito in primis funzioni lavorative e tipi di lavoro umano che sono specificamente razzializzati e femminilizzati (lavoro manuale, lavoro di cura, lavoro fatto dai poveri, i non educati, i colonizzati e le donne) e allo stesso tempo creato nuovi tipi di lavoro invisibilizzato che è performato dagli stessi soggetti sociali (data cleaning, human intelligence tasks etc). Per Atanasoski e Vora, le tecnologie dell’automazione (robot, AI, infrastrutture digitali, piattaforme) sorgono nel contesto di quello che Cedric Robinson in Black Marxism: the Black Radical Tradition (1983) chiamava capitalismo razziale. Per Robinson, il capitalismo è nato come estrazione di valore sociale e economico da soggetti dalle identità razziali marginalizzate. Tutto il capitalismo è intrinsecamente capitalismo razziale nella misura in cui non opera omogenizzando le differenze precedenti, ma le usa e le enfatizza per distinguere e differenziare le popolazioni. Secondo Robinson, il razzialismo è presente in tutta l’economia capitalista. Addirittura, secondo Denise Ferreira da Silva, l’equazione del valore nell’economia capitalista funziona proprio perché rende il valore prodotto dal lavoro razzializzato uguale a zero.
In realtà, come sottolineano le autrici, l’automazione del lavoro fino ad ora ha colpito e sostituito in primis funzioni lavorative e tipi di lavoro umano che sono specificamente razzializzati e femminilizzati (lavoro manuale, lavoro di cura, lavoro fatto dai poveri, i non educati, i colonizzati e le donne) e allo stesso tempo creato nuovi tipi di lavoro invisibilizzato che è performato dagli stessi soggetti sociali (data cleaning, human intelligence tasks etc). Per Atanasoski e Vora, le tecnologie dell’automazione (robot, AI, infrastrutture digitali, piattaforme) sorgono nel contesto di quello che Cedric Robinson in Black Marxism: the Black Radical Tradition (1983) chiamava capitalismo razziale. Per Robinson, il capitalismo è nato come estrazione di valore sociale e economico da soggetti dalle identità razziali marginalizzate. Tutto il capitalismo è intrinsecamente capitalismo razziale nella misura in cui non opera omogenizzando le differenze precedenti, ma le usa e le enfatizza per distinguere e differenziare le popolazioni. Secondo Robinson, il razzialismo è presente in tutta l’economia capitalista. Addirittura, secondo Denise Ferreira da Silva, l’equazione del valore nell’economia capitalista funziona proprio perché rende il valore prodotto dal lavoro razzializzato uguale a zero.
Il saggio di Atanasoski e Vora si inserisce in un filone di riflessioni attorno alle tecnologie digitali, e in particolar modo robotica e intelligenza artificiale, che pone il problema della relazione storica tra razza e tecnologia. Ci sono naturalmente approcci che enfatizzano il potenziale discriminatorio delle nuove tecnologie digitali, cioè il modo in cui vengono usati per riprodurre la discriminazione e lo sfruttamento razziale. Per esempio secondo Ruha Benjamin, le nuove tecnologie automatizzano le diseguaglienze e costituiscono a tutti gli effetti l’implementazione di nuove forme di segregazione (quello che chiama il “nuovo Jim Code”, riferendosi alle politiche segregazioniste negli Stati Uniti dopo la guerra civile che aveva portato all’abolizione formale della schiavitù) (Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code, Wiley 2019).
Anche per Wendy Chun, le tecniche e i modelli usati dalle piattaforme digitali (e quindi confluiti nell’IA) sono tendenzialmente discriminatory (Discriminating Data: Correlations, Neighborhood and the New Politics of Recognition, MIT Press 2021). Come sottolineato nel podcast della rivista L’Internazionale nel suo report sull’approvazione della nuova legislazione europea sull’Intelligenza Artificiale del 13 giugno 2023, quest’ultima non solo non offre nessuna protezione ai migranti ma li espone anche potenzialmente all’uso dell’AI contro di loro
.
Oltre a queste declinazioni apertamente discriminatorie delle tecnologie, esiste però anche un filone di riflessioni sulla natura costitutiva del rapporto tra razza e tecnologia. Già Louis Chude-Sokei in The Sound of Culture (Wesleyan University Press 2016), aveva sottolineato come razza e tecnologia abbiano storie parallele e relazioni culturali di lunga data. Per Chude-Sokei, il modo in cui conosciamo e capiamo la tecnologia è stato a lungo intrecciato con come abbiamo usato e costruito il senso della razza: “il linguaggio dell’una è consistentemente dipendente da e/o infetto con il pensiero sull’altro”. Secondo Chude-Sokei, la tecnologia, è sempre stata razzializzata o articolata in relazione alla razza e la robotica e la cibernetica erano in conversazione espliciti con metafore e analogie razziali.
Per Atanasoski e Vora, il “tecnoliberalismo” contemporaneo (quello rappresentato dal capitalismo di piattaforma o da quello che potrebbe essere definito un vero e proprio complesso di piattaforme corporative) riprende dunque questa relazione che si è formata nei tempi in cui, come Chude-Sokei riporta, i problemi più urgenti del mondo transatlantico erano l’industrializzazione e la schiavitù (cioè il diciannovesimo secolo). Nel ventunesimo secolo per Atanasoski e Vora, è l’ideologia tecnoliberista a promuovere l’idea che le macchine possano prendere il posto dei lavoratori e lavoratrici che fanno i lavori più umili, faticosi e ripetitivi permettendo al soggetto umano (identificato con soggetto maschile e bianco) di essere veramente umano (cioè creativo).
L’immaginario tecnologico utopico e paranoico si basa su questo desiderio e paura di tecnologie che agiscono come surrogati che liberano gli umani dal dover performare compiti storicamente degradanti. Gli oggetti tecnologici sono definiti come magici o incantati (robot che spazzano per terra, alexa che ci ricorda la lista della spesa o trova la musica che ci piace etc), cioè come tecnologie che intuiscono i bisogni umani e servono i desideri umani. L’effetto è quello di offuscare il lavoro dietro queste macchine per creare l’effetto magico dell’autonomia. Oggetti tecnici come Alexa e Roomba dunque riproducono e perpetuano il ruolo del lavoro non libero e invisible che sostiene l’apparente autonomia del soggetto liberale (lavoro servile, schiavizzato, lavoro di genere domestico). Il soggetto tecnoliberale immagina la tecnologia come magica e non il prodotto del lavoro umano invisibilizzato .

La storia del rapporto tra tecnologie, umano e non proprio umano inizia nel libro nella seconda metà del ventesimo secolo con l’egemoinia culturale statunitense, ma si focalizza sulle nuove tecnologie digitali, la robotica e l’AI (i tecno-oggetti e i discorsi politici che li inquadrano) per dissotterrare le storie oscure che delimitano i progetti ingegneristici tecnoliberali e il loro essere focalizzati su efficienza, produttività e accumulazione attraverso lo spossessamento. La modernità tecnologica è solo apparentemente neutrale in realtà è pervasa dalla politica razziale, di genere e sessuale della modernità basata sulla schiavitù razziale, la conquista coloniale, il genocidio e la mobilità forzata. Per quel che riguarda invece l’immaginario progressista liberale e/o radicale, il pericolo rimane quello di non tematizzare a sufficienza questo rapporto costitutivo tra razza, genere e tecnologia. L’idea di automazione come liberazione dal lavoro riproduce l’immaginario di razza e genere che definisce quali lavori competono all’umano e quali invece appartengono a gruppi sociali che non soddisfano l’ideale del pienamente umano (cioè definiti come meno che umani o non proprio umani).
Per Vora e Atanasoski, la “logica razziale di categorizzazione, differenziazione, incorporazione e eliminazione) è costitutiva del concetto di tecnologia e innovazione tecnologica e la tecnologia agisce come un surrogato del soggetto liberale – la cui libertà si basa sulla mancanza di libertà di qualcun altro (cioè del surrogato). Per Atanososki e Vora, il soggetto liberale (libero, autonomo, creativo, auto-determinato, individuale) si è costituito storicamente nella relazione tra se e quello che seguendo le orme di Toni Morrison e Saiddya Hartmann chiamano “il surrogato”, cioè il quasi umano o non proprio umano costituito da schiavi, donne, colonizzati. La libertà e l’autonomia dell’Uomo dipende dunque dal loro lavoro e dalla loro subordinazione. Il concetto di “surrogato” dunque richiama la storia dei surrogati umani (schiavi, colonizzati, donne, lavoratori invisibilizzati) e suggerisce che quando le tecnologie agiscono come ‘surrogati’’ esse ricapitolano le storie di invisibilizzazione che hanno sostenuto l’idea di soggetto liberale come agente del progresso storico. La prospettiva degli studi femministi e critici della razza sullo sviluppo tecnologico svela il modo in cui la progettazione e l’immaginazione dei tecno-oggetti (roomba, siri, alexa, cht GBT, Sofia) re-incanti compiti tradizionalmente visti come espressione di un lavoro noioso, sporco e non creativo.
Il tecnoliberalismo sostiene che stiamo entrando in una nuova fase dell’emancipazione umana liberata dalle vecchie oppressioni di razze, genere e lavoro, attraverso lo sviluppo tecnologico, ma in realtà le perpetua. Per Ruha Benjamin, la tecnologia è una metafora per i processi di innovazione dell’ineguaglianza dove la supremazia bianca è l’opzione default. Per Atanasoski e Vora, la razza è la condizione delle possibilità stessa dell’emergere della tecnologia come categoria epistemologica, politica ed economica nella modernità Euro-Americana. Il tecnoliberalismo si presenta come post-razziale, cioè come un mondo in cui le differenze di razza non sono più rilevanti, ma secondo la critica contemporanea esso invece rinnova un immaginario razzializzato proiettandolo sulle macchine.
Nella lettura di Denise Ferreira da Silva della serie tv Black Mirror, per esempio, quest’ultima viene letta come la rappresentazione immaginaria del futuro di un altro presente rispetto a quello della pandemia del 2020. Black Mirror è il futuro dell’America di Barack Obama, quando si diffonde l’idea di post-razziale. La serie infatti non performa le classiche strategie di assoggettamento dei razzializzati: i personaggi interpretati da attori e attrici non bianchi sono presenti e però non interpretano personaggi stereotipati. E però la razza (la blackness) persiste in quello schermo nero che indica la condizione di essere sussunti dalla macchina come una condizione di in-dignità (perdita di dignità) che implicitamente evoca la condizione razzializzata. Il futuro rappresentato dal 2020, l’anno della pandemia di Covid-19 e di Black Lives Matter, smentisce il discorso tecnoliberista post-razziale mettendo invece in scena l’esplosione della perfetta tempesta razziale: i dati e le curve statistiche riproducono l’ingiustizia sanitaria che vede i nonbianchi colpiti più duramente in termini di vittime, mentre si diffondono in rete le immagini degli ennesimi omicidi da parte della polizia di afroamericani come George Lloyd.
Come già diceva Franz Fanon, la deloconizzazione significa anche la sostituzione di una certa specie di umani (quella che ha sotteso la colonizzazione) con un’altra. Vedere come la grammatica razziale e il suo immaginario funziona nei discorsi e nell’immaginario sulle macchine permette di pensare a “relazioni tra umano e macchina che sono fuori la triade del modo di produzione capitalista uso-valore-efficienza”. Queste relazioni per Atanasoski e Vora possono essere rintracciate in progetti artistici e ingegneristici che cercano di creare tecnologie che sfumano i confini tra soggetto e oggetto, produttivo e improduttivo avanzando strutture relazionali inimmaginabili nel presente (oltre il soggetto del lavoro o dei diritti umani).
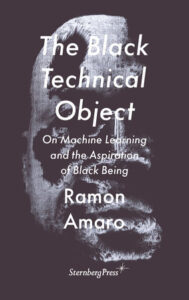
A questo fa riferimento per esempio anche il recentissimo testo di Ramon Amaro The Black Technical Object: on Machine Learning and the Aspiration of Black Being (Sternberg Press, 2023) dove si prefigura una nuova consapevolezza della possibilità di un modo di esistenza del machine learning e del “Black being” che costituisca un terreno alternativo per il pieno potenziale della Blackness e dell’oggetto tecnico nella prospettiva aperta da Franz Fanon di una “effettiva dis-alienazione” dell’algoritmico, del futuro del machine learning e di quello degli esseri razzializzati.
Ed allora è dalla trilogia di Octavia Butler sui telepati o Patternmaster, o dalla fantascienza dei film di Jordan Peele e Boots Riley, o dallo Stack dell’Atlantico Nero, con la sua furutythmmachine e la sua “intelligenza distribuita, decentralizzata e sintetica che mobilizza una matematica sensuale che astrae affetti, concretizza cognizione, calcola movimenti e muove i calcoli”, che, per esempio, diventa possibile immaginare queste possibilità (Luciana Parisi e Steve Goodman “Golemology, Machines of Flight and SF Capital”, e-flux 2021)


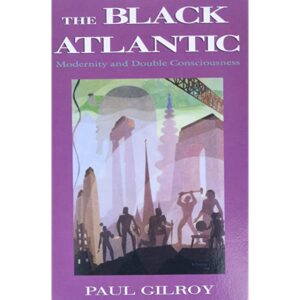



 Consider the famous rebetika singer Rosa Eskenazi, a Turkish-speaking Sephardic Jew born in Istanbul and raised in Thessaloniki and Athens. Rosa perfected her art in the taverns of Piraeus, singing in Greek, Turkish, Arabic, Hebrew, Italian, Ladino and Armenian. At the height of her fame in the 1930s, she recorded in Athens and Istanbul. Her biography is only one of the multiple musical maps transmitted around the Mediterranean where to paraphrase Ralph Ellison; one loses one’s identity to find it.
Consider the famous rebetika singer Rosa Eskenazi, a Turkish-speaking Sephardic Jew born in Istanbul and raised in Thessaloniki and Athens. Rosa perfected her art in the taverns of Piraeus, singing in Greek, Turkish, Arabic, Hebrew, Italian, Ladino and Armenian. At the height of her fame in the 1930s, she recorded in Athens and Istanbul. Her biography is only one of the multiple musical maps transmitted around the Mediterranean where to paraphrase Ralph Ellison; one loses one’s identity to find it.


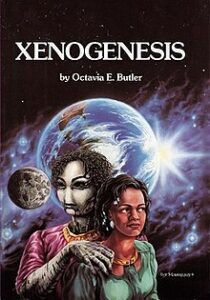 Gli Oankali e gli Ooloy, esseri coperti di tentacoli, superano le frontiere del sentire e del fare, di genere o stirpe e di generi sessuali. A favore di una maternità collettiva, non esclusivamente femminile o umana, propongono il transito, un ponte tra le differenze, in accostamenti e assemblaggi riproduttivi inusitati; attraverso i tentacoli sentono, tastano, comunicano, godono, procreano e danno forma al mondo circostante. …La contaminazione tra maschile e femminile, umani e alieni, è desiderio e legge per questi esseri che hanno bisogno dell’umano, necessario alla creazione simbiogenetica.
Gli Oankali e gli Ooloy, esseri coperti di tentacoli, superano le frontiere del sentire e del fare, di genere o stirpe e di generi sessuali. A favore di una maternità collettiva, non esclusivamente femminile o umana, propongono il transito, un ponte tra le differenze, in accostamenti e assemblaggi riproduttivi inusitati; attraverso i tentacoli sentono, tastano, comunicano, godono, procreano e danno forma al mondo circostante. …La contaminazione tra maschile e femminile, umani e alieni, è desiderio e legge per questi esseri che hanno bisogno dell’umano, necessario alla creazione simbiogenetica.
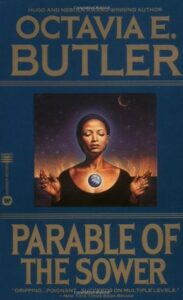 violenza e guerra. Al suo primo nome, ispirato a una pianta, è aggiunto quello della dea Oya, la Orisha della cultura yoruba nigeriana, figura tra la santeria brasiliana e la Vergine Maria del cattolicesimo. Come creatrice di mondi, ha il potere di comandare venti, tempeste e morte con i suoi nove tentacoli, in consonanza con i nove affluenti del fiume Niger – tra natura e cultura
violenza e guerra. Al suo primo nome, ispirato a una pianta, è aggiunto quello della dea Oya, la Orisha della cultura yoruba nigeriana, figura tra la santeria brasiliana e la Vergine Maria del cattolicesimo. Come creatrice di mondi, ha il potere di comandare venti, tempeste e morte con i suoi nove tentacoli, in consonanza con i nove affluenti del fiume Niger – tra natura e cultura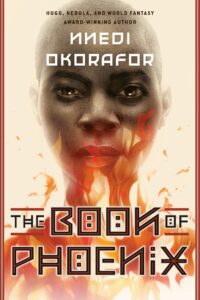 Il tema della schiavitù e del riscatto nella cornice di un afrocentrismo ancora più accentuato è presente in molta della fantascienza recente. In The Book of Phoenix (2015) di Nnedi Okorafor il motivo del volo riconduce a Butler: le ali con cui Phoenix rinasce le permetteranno di volare da New York al Ghana, dove, sia pure per un tempo breve, ritroverà origine, lingua nativa e solidarietà, diventan- do Phoenix Okore (Fenice Aquila). Anche The Broken Earth Series (2016-18) di Norah K. Jemisin racconta una saga disperata su un pianeta distrutto, chiedendosi cosa si può salvare dell’umanità o se questa è al di là di ogni redenzione….
Il tema della schiavitù e del riscatto nella cornice di un afrocentrismo ancora più accentuato è presente in molta della fantascienza recente. In The Book of Phoenix (2015) di Nnedi Okorafor il motivo del volo riconduce a Butler: le ali con cui Phoenix rinasce le permetteranno di volare da New York al Ghana, dove, sia pure per un tempo breve, ritroverà origine, lingua nativa e solidarietà, diventan- do Phoenix Okore (Fenice Aquila). Anche The Broken Earth Series (2016-18) di Norah K. Jemisin racconta una saga disperata su un pianeta distrutto, chiedendosi cosa si può salvare dell’umanità o se questa è al di là di ogni redenzione…. In questa apocalisse il corpo femminile nero è, a un tempo, indice e sintomo della devastazione incombente ma anche rappresentazione di riscatto e resistenza. Come ha detto mirabilmente Hortense Spillers (1987), se la “donna nera” è una figurazione particolare del soggetto diviso della modernità, ne è anche la sua più profonda rivelazione.
In questa apocalisse il corpo femminile nero è, a un tempo, indice e sintomo della devastazione incombente ma anche rappresentazione di riscatto e resistenza. Come ha detto mirabilmente Hortense Spillers (1987), se la “donna nera” è una figurazione particolare del soggetto diviso della modernità, ne è anche la sua più profonda rivelazione.
 “Undercommons
“Undercommons