Qualcosa è successo, qualcosa sta succedendo e qualcosa succederà.
Quando parliamo di archivi parliamo di memorie.
Uno dei terrori più antichi dell’umanità, come individui e come gruppi, è perdere la memoria.
Perciò la tecnologia a supporto della Memoria, che nei tempi antichi erano la parola, il canto, la poesia, sostenute dalle regole del ritmo, dei toni, della giusta pronunzia e dalla forza della voce, era tenuta nel massimo conto, era arte sacra.
Mnemosine era una divinità, una delle sette Muse.
Senza memoria non si produce poesia non si produce visione, non si puo fare del momento presente il nodo tra passato e futuro.
Queste preziosissime memorie, semi di ogni storia si sono organizzate nel tempo in raccolte detti archivi.
Queste raccolte, prima orali, trasmesse a volte in forma di poemi visionari cantati, come l’Iliade, l’Odissea, il Mahabarata, poi in forma di scrittura sono il materiale che costituisce il Sapere, la Storia, il Mito in cui la comunità si riconosce come autore e fruitore.
Qualcosa sta succedendo
A Napoli da qualche mese, in un discreto, silenzioso crescendo di incontri, relazioni e azioni si sta costruendo la Manovra Napoli, come si è deciso di chiamarla per semplicità e verità effettiva.
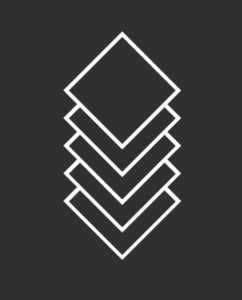
Nata per nutrirsi di e nutrire eventualmente la memoria e l’archivio di memorie della città, ad opera del Genio Collettivo e dei movimenti che via via si stanno aggregando supportandola con mezzi materiali e immateriali ( spazi, persone,idee, denaro) è stata presentata in società a puntate, tra dicembre 2017 e gennaio 2018, nel corso di Assemblee per l’archivio Cubotto_Manovra Napoli.
La Manovra Napoli (e subito viene in mente quella creatura particolarmente cara all’ immaginario cittadino che è il purpo, in italiano piovra) quindi è un processo che partorirà a sua volta una creatura che per ora, giocando con “mamma” e “base” tra il l’italiano base, fondamento l’equivalente inglese, ha nome Mamabase.
per la costruzione di un archivio dei movimenti sociali, ma anche delle storie comuni, dei ricordi, delle lotte, della produzione culturale.Mettere insieme una storia collettiva. Raccoglierla per non disperderla, per condividerla e trasportarla nel tempo. Ma anche per farla rivivere, permetterle di raccontare ancora e ancora,attraverso un software open source (cubotto.org), in una rete confederata di archivi costruita dal basso, internazionale, su di una infrastruttura propria non affidata alle grandi compagnie dei big data.[…] Solo alcuni racconti tra tanti, selezionati scientemente, costruiscono la Storia. Solo alcuni racconti sono l’Archivio su cui si siede il Dominus, quello che muove i fili della sceneggiata spettacolare del presente continuo, investendosi dell’Autorità (ancora una A maiuscola) di decidere per gli altri.
Tutte le memorie che si sono prodotte collettivamente, mentre si costruivano e agivano i movimenti che hanno fatto pensiero, cultura, arte e politica negli ultimi anni, a Napoli, in forma di documenti fotografici, filmici, audio, sono potenzialmente parte di quest’archivio a venire.
Gli spazi fisici e immateriali del racconto di una città, Napoli in questo caso, sono da sempre lo spazio culturale da colonizzare.
Se è vero che la città possiede una indubbia capacità di raccontarsi facendosi mito e poesia condivisi (a volte in un eccesso di autoreferenzialità fine a se stesso), i processi di integrazione, assorbimento, inclusione, digestione di questi racconti e di queste autonarrazioni – messi in atto dal capitale neo liberista, dalla modernità, dal mercato globale dal pensiero eurocentrico, dallo sguardo neo coloniale orientalista, ecc. ecc. che dir si voglia, qual si voglia – attraverso la costruzione di favole egemoniche, capaci di annullarne differenze, diversità e specificità, producono opportunamente appiattimento ed essenzializzazione.
Sembra che, mai come in questo momento, la città sia pericolosamente e non del tutto consapevolmente, al centro di un’attenzione morbosa in grado di disinnescare il valore positivo di di questa innata capacità mitopoietica.
Il brand “napoli-città diversa caotica e anarchica e vitale” è attualmente una delle leve più potenti per la commercializzazione a scopo turistico e per la riduzione di tutto quello che si sta producendo e pensando a uno sguardo che rassicura e chiude la questione nel recinto delle eventuali “manifestazioni di diversità esotica”. Il risultato è che gli spazi della città, intesi come spazi di pensiero e di azione culturale e politica, dopo questo processo di sterilizzazione e cambio di segno, rientrano via via – e da sempre – come icone di identità pre-moderne, indifferentemente accanto ai pastori di S. Gregorio Armeno, alle cape di morto delle Fontanelle, alle cene nei bassi con autentiche “vaiasse”, ad alimentare l’ambito sempre innocente dell’antico, autentico desiderio dell’altro, del differente, della possibilità alternativa.
È così che possibili vie rivoluzionarie, visioni altre, istanze radicali si riducono a beni-merci di consumo: itinerari trasgressivo-turistici acquistabili e consumabili nell’arco di un weekend, oggetti-opere, materiali o immateriali di artisti, talvolta furbi e ingenui, destinati al collezionismo e/o al consumo culturale-finanziario del sistema dell’arte.
È così che queste direzioni di fuga intese come possibilità di costruzione alternativa del mondo, prodotte da parole e immaginazioni diverse partorite dagli abitanti di questo piccolo spazio del pianeta, di nome Napoli, rientrano nell’Archivio della narrazione egemone, sterilizzate, bonificate e finalmente innocue.
Quante e quali sono le linee di altri futuri possibili, perdute nello svolgersi del tempo-spazio- racconto della città, anche solo guardando agli ultimi 30 anni?
Sepolte, nascoste o dimenticate ma comunque sopravvissute da qualche parte, grazie a collezionisti, flâneurs, addetti ai lavori curiosi e malati d’archivio, in forma di fotografie, filmini e quant’altro, queste memorie e documenti conservano intatto, come un seme non più o non ancora germogliato, una potenza sovversiva.
Perciò raccoglierle, guardarle insieme confrontarle, come si fa con i vecchi album di famiglia serve, mai come ora: per acquisire una coscienza individuale e collettiva di quello che si è stati già capaci di produrre, magari attraverso più di una generazione; per imparare ancora una volta che se si è già stati capaci di pensare diversamente, siamo e saremo ancora capaci di produrre differenza di pensiero e azioni; per confrontarsi e imparare dagli sbagli quello che non si deve fare e quello che è più opportuno fare; per riprendere il filo di discorsi e racconti interrotti che ancora dispiegano, vive, prospettive e visioni da percorrere.
L’essere umano è la sua capacità di ricordare e immaginare, adesso più di prima, nel tempo in cui, quasi insensibilmente, stiamo esternalizzando questa capacità, tagliando in maniera sempre più definitiva il rapporto tra memoria e voce, memoria e visione, memoria e relazione con l’altro. Affidando sempre più alla macchina, la capacità di conservare la memoria.
Spesso nell’illusione che la memoria fuori di noi sia molto più affidabile, vasta e precisa di quella di un singolo umano, stiamo mettendo l’enorme ricchezza-capacità-potere che è il tutt’uno del ricordare-essere-immaginare, fuori di noi, individui e collettività, in mani altrui.
Allo stesso tempo, paradossalmente, siamo tutti più o meno consapevoli o almeno a conoscenza del fatto che quello che produciamo, semplicemente duplicando in rete il nostro ricordare-essere-immaginare, ovvero vivere individuale e collettivo in termini di informazioni e dati, sono la vera ricchezza: sappiamo senza dubbio che siamo noi il capitale di questo tempo.
Mettere insieme queste ricchezze, sia materialmente in un archivio digitale ovvero il cubotto, sia del punto di vista dell’incontrarsi, dello stabilire una relazione consapevole con queste ricchezze, con questa capacità di produrre visioni, riappropriandosi prima di tutto dell’umano, affettivo, visionario e politico, che sottende queste ricchezze, è un’operazione autoriflessiva estremamente importante in questo momento. Significa riprendersi la propria voce, letteralmente, la propria capacità di ricordare-essere-immaginare.
Se l’equazione archivio-memoria-dati-capitale è vera, se è vero che mai come ora sottile e grossolano, materiale e immateriale coincidono, questa certamente non è un’operazione senza rischi.
La macchina come tecnologia non dà garanzie, non è Dio, come abbiamo, per fortuna da tempo scoperto. Il rischio che questa ricchezza enorme possa andare in mani e cuori sbagliati esiste, al di la delle buone intenzioni, come esiste il rischio del bug tecnologico.
Non c’è, come è ovvio che sia, nessun futuro garantito.
È il caso comunque di prendersi il rischio focalizzandosi, più che sull’interrogativo inesauribile “che garanzia e quale futuro per questi archivi/ricchezze?”, sul presente della performance dell’apertura e condivisione di questi archivi, che nel momento vero dell’incontro possono produrre e stanno già producendo autoriflessione, cioè domande essenziali.
Almeno una parte-piccola ma non trascurabile, della città, si sta chiedendo dove siamo? cosa siamo? da dove siamo venuti? dove eventualmente possiamo andare ed essere per il futuro? Cercando di immaginare un futuro.
Qualcosa è (già da tempo) successo
C’è un filo del discorso che dura da anni tra diverse persone.
In un assolato pomeriggio-sera di luglio ai piedi del vulcano Etna, circa 7-8 anni fa, alcune persone, si incontrano al piano nobile di una antica casa di campagna in rovina, decorata da affreschi in rovina, nel mezzo della valle del Simeto.
In questa rovina di casa e paesaggio che sembra la scena costruita apposta per raccontare il paesaggio culturale in cui siamo immersi tutti da anni, si inizia a tessere la tela delicata sui cui ancora stiamo producendo pensieri visioni e affetti.
Si parla di Storia, di come la storia si fa mito, di storie rimaste fuori dalla storia, di archivi perduti, di memoria, visione e poesia.
Già da tempo il piccolo angolo di mondo, che ci siamo costruiti, noi abitanti dell’emisfero nord del pianeta, grosso modo da quando Colombo ha “scoperto” l’America, è stato dichiarato affetto da mal d’archivio e mania della rovina.
Ci sono stati i profeti e i veggenti del morbo, da Nietzche a Benjamin, i sapienti che per primi hanno annusato il morbo poi alcuni saggi hanno annunciato che la (nostra) Storia è finita e che abbiamo perso il futuro. In concomitanza il nostro presente è diventato (anche) digitale.
Oggi, che il morbo sembra aver assunto carattere endemico, persone comuni come noi e anche alcuni specialisti cominciano a pensare che il morbo non è veramente malattia, che piuttosto è una mania e una malia d’amore.
E’ una passione che ha sede nel cuore, che guarda con scioltezza avanti e indietro nel tempo e nello spazio, tornati ad essere la stessa cosa, come ai tempi di Omero e del Mahabaratha, in un sguardo che è sempre nel presente.
La Malinconia non è più quella di una volta, come dice il bel titolo di un articolo di Beatrice Ferrara.
Successivamente il filo mai interrotto di questa conversazione ha incrociato le sperimentazioni e le invenzioni di un manipolo di creature ipertecnologiche, tanto malate e ammaliate dall’algoritmo e dalla scrittura binaria, quanto noi eravamo malati di archivi materiali e immateriali.
Da questi incontri, passando per Milano, in residenza a Macao è nata la sperimentazione del Cubotto, ad opera del Genio collettivo
un software open source sviluppato con l’intento di facilitare la raccolta, la catalogazione, la valorizzazione, la fruizione, la distribuzione e l’uso di oggetti audiovisivi e non (suono, video, foto, testi) da parte di un numero illimitato di persone in un contesto di lavoro sia locale che remoto. La visione che ha guidato questo processo di sviluppo collettivo durato più di un decennio muove i suoi passi dalla necessità di fornire strumenti a basso costo per la costruzione di una federazione di archivi condivisi senza un centro, una costellazione di persone e macchine che a partire dal mediterraneo, dal sud, può dare luogo alla stratificazione di una storia non di dominio, non di potere, ma popolare,
dice il testo della call per Opere in lotta in occasione della prima uscita publica durante l’evento Sensibile comune: Le opere vive (a cura di Ilaria Bussoni, Nicolas Martino, Cesare Pietroiusti), tenutosi alla Gnam nel gennaio 2017.
e qualcosa succederà
Dopo questa prima uscita pubblica Cubotto e Genio Collettivo hanno sperimentato il contesto della 53a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro a giugno 2017, per tornare di nuovo a Sud a Napoli.
MamaBase è il neonato progetto di archivio delle lotte sociali e delle autoproduzioni che si sta sviluppando a Napoli tra varie realtà e in rete con altri archivi della rete Cubotto.
Siamo nel terzo millennio e il digitale è la forma e il mezzo è il luogo in cui si raccolgono memorie.
Da Aprile, al terzo piano dell’Ex Asilo Filangieri, ogni martedì e giovedì, a partire dalle 15 sino a sera tarda, funzionerà un laboratorio, un point, per chi volesse consegnare materiale o anche ragionare-praticare-fare l’archivio, mentre presso il Giardino Liberato di Materdei sono già presenti i due server che costituiranno la rete Cubotto di Napoli.
Ci si augura non tanto una copiosa raccolta dati quanto un momento di autoriflessione, attraverso l’archivio, fatto di incontri di visioni e revisione condivise di passati prossimi o remoti, di parole e relazioni che aprano al nuovo guardando indietro.
“Costruire un altro Archivio, aprendo gli archivi di quello che è scartato, escluso dalle narrazioni dominanti, può consentire il racconto di altre storie, costruire altri pensieri, immaginare altre culture. Perciò lavorare l’archivio, farlo, aprirlo, metterlo in discussione è un’ azione culturale e politica radicale”.







 L’artista digitale Jacque Njeri, per esempio, fa dialogare la tradizione del mito Maasai keniota con i tropi afrofuturistici del viaggio nello spazio e della vita su altri pianeti, dando vita a MaaSci, titolo nato dalla fusione delle parole ‘Maasai’ e ‘sci-fi’. L’opera è presentata come una raccolta di stampe grafiche che documentano il viaggio nello spazio della comunità MaaSci. La leggenda, rivisitata dall’artista, narra di una coppia (moglie e marito) che dalla Silicon Savannah parte in esplorazione dello spazio. I due ritorneranno con artefatti provenienti dalla Luna e da altri pianeti, grazie ai quali sarà possibile intrattenere scambi con altre comunità tribali più ricche, così da assicurare ai MaaSci l’approvvigionamento di acqua e risorse alimentari. La memoria del viaggio nello spazio – una narrazione a cui l’artista si riferisce col termine ‘Shestory’ – è appuntata su una pergamena e consegnata alla comunità delle donne MaaSci, depositarie della tecnica e della conoscenza scientifica. Alle donne che, sfidando i costrutti di genere, si dedicano ad occupazioni tradizionalmente maschili, quali lo studio della scienza e dell’ingegneria, si deve infatti la messa a punto delle tecnologie e delle astronavi che continueranno a mandare i MaaSci, nomadi celestiali, nello spazio.
L’artista digitale Jacque Njeri, per esempio, fa dialogare la tradizione del mito Maasai keniota con i tropi afrofuturistici del viaggio nello spazio e della vita su altri pianeti, dando vita a MaaSci, titolo nato dalla fusione delle parole ‘Maasai’ e ‘sci-fi’. L’opera è presentata come una raccolta di stampe grafiche che documentano il viaggio nello spazio della comunità MaaSci. La leggenda, rivisitata dall’artista, narra di una coppia (moglie e marito) che dalla Silicon Savannah parte in esplorazione dello spazio. I due ritorneranno con artefatti provenienti dalla Luna e da altri pianeti, grazie ai quali sarà possibile intrattenere scambi con altre comunità tribali più ricche, così da assicurare ai MaaSci l’approvvigionamento di acqua e risorse alimentari. La memoria del viaggio nello spazio – una narrazione a cui l’artista si riferisce col termine ‘Shestory’ – è appuntata su una pergamena e consegnata alla comunità delle donne MaaSci, depositarie della tecnica e della conoscenza scientifica. Alle donne che, sfidando i costrutti di genere, si dedicano ad occupazioni tradizionalmente maschili, quali lo studio della scienza e dell’ingegneria, si deve infatti la messa a punto delle tecnologie e delle astronavi che continueranno a mandare i MaaSci, nomadi celestiali, nello spazio.

 Il viaggio nello spazio continua per i visitatori della mostra nel lavoro di
Il viaggio nello spazio continua per i visitatori della mostra nel lavoro di  Un monito, questo, e un invito a prendere coscienza del fatto che il futuro è preparato in itinere, e non c’è modo di immaginarne un altro libero dal ricordo. “Planet AiRich – si legge ancora sullo schermo – è una stazione di disintossicazione, un rifugio per il rinnovamento”, uno spazio per la pratica della memoria (remembrance) e la cura di coloro che sono (stati) danneggiati.
Un monito, questo, e un invito a prendere coscienza del fatto che il futuro è preparato in itinere, e non c’è modo di immaginarne un altro libero dal ricordo. “Planet AiRich – si legge ancora sullo schermo – è una stazione di disintossicazione, un rifugio per il rinnovamento”, uno spazio per la pratica della memoria (remembrance) e la cura di coloro che sono (stati) danneggiati.


 Archeologia, etimologicamente, vuol dire “discorso delle cose antiche”. Bisogna ricordare giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo; sotterrare e dissotterrare miti in accordo con quello che (ci) succede intorno; scombinare l’ordine cronologico del tempo, cambiare i confini alla geografia, i numeri alla matematica, per accorgersi che il futuro non esiste: è una performance. E non sono forse queste – le performance – dei continui riadattamenti della memoria?
Archeologia, etimologicamente, vuol dire “discorso delle cose antiche”. Bisogna ricordare giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo; sotterrare e dissotterrare miti in accordo con quello che (ci) succede intorno; scombinare l’ordine cronologico del tempo, cambiare i confini alla geografia, i numeri alla matematica, per accorgersi che il futuro non esiste: è una performance. E non sono forse queste – le performance – dei continui riadattamenti della memoria?

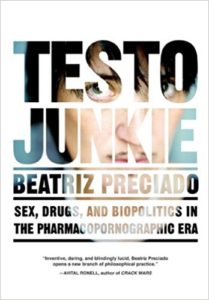








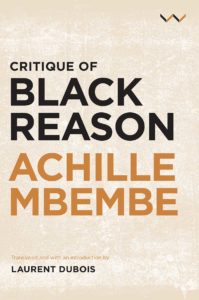


 Una interrogazione sul senso dell’archivio è in senso più vasto e più sottile un discorso sulla memoria. Iniziamo dalla pratica artistica con l’intento di irrompere, provocare o evocare l’Archivio, non solo di raccogliere e mettere insieme memorie e memorabilia, per tentare di eluderne la natura mortuaria e monumentale. Il digitale, la rete, la dimensione 2.0, hanno facilitato l’emersione e l’accesso potenziale a un numero illimitato di archivi, ma ogni singolo frammento di questo ARCHIVIO venuto alla luce è condannato, potenzialmente, contestualmente a scomparire nell’oblio della rete.
Una interrogazione sul senso dell’archivio è in senso più vasto e più sottile un discorso sulla memoria. Iniziamo dalla pratica artistica con l’intento di irrompere, provocare o evocare l’Archivio, non solo di raccogliere e mettere insieme memorie e memorabilia, per tentare di eluderne la natura mortuaria e monumentale. Il digitale, la rete, la dimensione 2.0, hanno facilitato l’emersione e l’accesso potenziale a un numero illimitato di archivi, ma ogni singolo frammento di questo ARCHIVIO venuto alla luce è condannato, potenzialmente, contestualmente a scomparire nell’oblio della rete.


